
I TERRIBILI SEGRETI DI MAXWELL SIM, Jonathan Coe, Feltrinelli

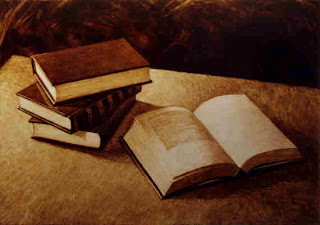 violenta e, in qualche modo, belluina.
violenta e, in qualche modo, belluina.E' una raccolta commentata di brani tratti dai libri che sto leggendo, una specie di antologia sul web.


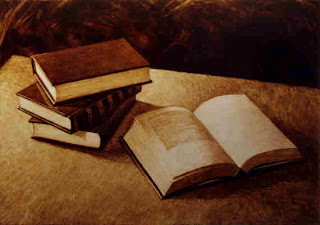 violenta e, in qualche modo, belluina.
violenta e, in qualche modo, belluina.


May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others Testo trovato su http://www.testitradotti.it
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.
May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.
May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young
Forever young, forever young,
May you stay forever young.
Bob Dylan
Esiste un testo più bello di questo?
http://www.youtube.com/watch?v=Hc-a1kP7ITA&feature=player_embedded
(bella versione "cartone animato" del testo
 QUELLO ERA L'ANNO, Dennis Lehane, Piemme
QUELLO ERA L'ANNO, Dennis Lehane, Piemme



 |
| Amy Chua con le figlie |
Di che si tratta? L'autrice Amy Chua, una professoressa di Legge alla Law School dell'Università di Yale, insegna a tirar su i propri figli per farli diventare piccoli geni in matematica vedi i risultati degli studenti di Shanghai negli ultimi test Pisa dell'Ocse e prodigi nella musica. Alla base del successo dei giovani cinesi, sostiene Chua, c'è infatti il metodo educativo imposto dalle madri cinesi.
Avete presente le dolcissime mamme italiane super apprensive e iper protettive con i loro bambini anche quando non sono più bambini? Ebbene le mamme cinesi sono esattamente l'opposto dello stereotipo italiano. La madre italiana è una chioccia, quelle cinese è una tigre. Come suggerisce il titolo del libro da cui è estratto il saggio di Chua, «Inno di battaglia della madre tigre».
Il metodo cinese è fatto di disciplina, rigore e severità, all'ennesima potenza. Secondo l'autrice è proprio la coercizione che porta ad eccellere. Ed elenca alcune delle regole messe in pratica con le sue due figlie, Sophia e Louisa. Il decalogo include non invitare o andare dagli amici a giocare, non dormire fuori casa, non guardare la tv o giocare con i videogames, non lasciare ai figli la scelta delle attività extra-scolastiche, pretendere il massimo dei voti.
Troppo? Perfino quando i genitori occidentali pensano di essere severi non si avvicinano neppure lontanamente alle madri cinesi. Per dare un'idea, Chua racconta come riuscì a far imparare a Louisa, quando aveva circa 7 anni, a suonare al pianoforte un pezzo del compositore francese Jacques Ibert, «Il piccolo asino bianco». Un pezzo molto bello, ma assai complicato per una bambina, perché «le mani devono suonare ritmi completamente diversi in modo schizofrenico», ricorda. Lulu non riusciva a suonarlo. Nemmeno dopo una settimana di esercitazioni non stop. Così la madre tigre diventa un'aguzzina. Nasconde l'amata casa delle bambole della figlia, e promette di regalarla pezzo a pezzo all'Esercito della Salvezza, se non imparerà «Il piccolo asino bianco» alla perfezione per l'indomani. Minaccia di farle saltare pranzo e cena, di non farle più regali a Natale, di abolire la festa di compleanno per 2, 3, 4 anni di fila. La offende chiamandola pigra, codarda, smidollata, patetica.
Nemmeno l'intervento del marito Jed ferma la madre tigre, perché quelli non sono insulti, lei sta «solo motivando» la figlioletta, si giustifica. La madre tigre è disposta ad «essere odiata». Ma non rinuncia al suo metodo. Così torna dalla figlia e continua a torturarla, usando «ogni arma e tattica» che le viene in mente. Madre e figlia provano al piano per tutta la sera fino a notte fonda, saltando la cena. Lulu non può alzarsi nemmeno per bere o per andare in bagno. La casa ormai è «una zona di guerra», piena di urli. Poi all'improvviso Lulu riesce a suonare il pezzo. È «talmente raggiante» che non vorrebbe più smettere di suonare.
La morale di Chua è che i genitori occidentali si preoccupano molto dell'autostima dei loro figli. Ma come genitore, una delle cose peggiori che si possono fare per l'autostima del proprio figlio è di farlo arrendere davanti a un ostacolo, dice. Non c'è niente di meglio per acquistare fiducia che scoprire di poter fare qualcosa che non si pensava di saper fare.
Ma può l'eccellenza nella musica o in altre discipline scientifiche fare la felicità dei nostri figli? E bastano queste abilità per avere successo nella vita? Su questi dilemmi si stanno confrontando i lettori. A valanga. Nei post si trova di tutto. Certo, prevale l'indignazione per il sistema da lager. Che ne è inoltre, molti si chiedono, della creatività, della socialità, dell'importanza di imparare a fare squadra? Il metodo cinese, però, riscuote anche consensi, soprattutto da quanti e non sono pochi credono che il permissivismo dei Paesi occidentali sia andato troppo oltre. Di sicuro il tema è «caldo», perché tocca temi sensibili come l'educazione dei figli, le differenze culturali e il nazionalismo. La discussione è aperta.
Giuliana Ferraino


 Che destino!
Che destino!

I ricercatori hanno scoperto quasi per caso, durante una sperimentazione non collegata, che le persone con una convinta fede religiosa tendono ad essere più contente nella vita. Nonostante non fosse l’obiettivo principale della ricerca, il recente studio europeo ha chiarito che gli individui religiosi sono più abili nel fronteggiare shock e dolori come la perdita di una persona cara o di un lavoro.
Il professor Andrew Clark della Paris School of Economics e il co-autore Dr. Orsolya Lelkes dell’European Center for Social Welfare Policy and Research hanno analizzato una varietà di fattori su individui Cattolici e Protestanti e hanno riscontrato che la soddisfazione sembra raggiungere livelli più elevati nelle popolazioni religiose. Gli autori hanno concluso che la religione in generale agirebbe come una sorta di “cuscinetto” che protegge l’individuo dalle difficoltà della vita.
“Abbiamo iniziato la ricerca per comprendere come mai alcune nazioni europee abbiano sussidi di disoccupazione più alti delle altre ma la nostra analisi ha evidenziato subito che le persone credenti soffrivano meno dei non credenti il disagio psicologico derivante dalla perdita del lavoro”, spiega il Prof. Clark.
 I dati di centinaia di famiglie europee rivelano livelli molto più elevati di soddisfazione generale nei credenti e il Prof. Clark sospetta che la ragione stia in una molteplicità di aspetti. Certo, l’idea che la religione possa offrire un sostanziale beneficio psicologico nella vita contrasta vivamente con la visono comune della religione come ente oppressivo che ha una influenza negativa sullo sviluppo umano. Il Prof. Leslie Francis dell’Università di Warwick ritiene che i benefici derivino dalla visione religiosa di un maggiore “senso della vita” che viene vissuto da molti credenti e che potrebbe essere minore nei non credenti. “Queste conclusioni contrastano infatti con una visione dominante che invece sostiene che la religione possa condurre al dubbio, al fallimento e quindi abbia effetti negativi”, dice Francis, “La convinzione che la religione danneggi le persone è ancora molto diffusa”.
I dati di centinaia di famiglie europee rivelano livelli molto più elevati di soddisfazione generale nei credenti e il Prof. Clark sospetta che la ragione stia in una molteplicità di aspetti. Certo, l’idea che la religione possa offrire un sostanziale beneficio psicologico nella vita contrasta vivamente con la visono comune della religione come ente oppressivo che ha una influenza negativa sullo sviluppo umano. Il Prof. Leslie Francis dell’Università di Warwick ritiene che i benefici derivino dalla visione religiosa di un maggiore “senso della vita” che viene vissuto da molti credenti e che potrebbe essere minore nei non credenti. “Queste conclusioni contrastano infatti con una visione dominante che invece sostiene che la religione possa condurre al dubbio, al fallimento e quindi abbia effetti negativi”, dice Francis, “La convinzione che la religione danneggi le persone è ancora molto diffusa”.
Terry Sanderson, presidente della National Secular Society e attivista per i diritti degli omosessuali, ritiene che uno studio come quello riportato sopra e che traccia un collegamento fra la felicità e la fade sia “senza senso”. “I non credenti non possono rivolgersi alla religione per essere felici. Se trovi incredibili le fondamenta della religione, non riuscirai a crederci, qualsiasi sia la ricompensa che ne deriva”, dice Sanderson. “La felicità, comunque, è un concetto elusivo. A me da felicità l’ascolto della musica classica, mentre guardare il football mi da repulsione. Qualcun altro proverà l’esatto opposto. Alla fine tutto si riduce al gusto e alla predisposizione personale.”
Justin Thacker, capo della Theology for the Evangelic Alliance, crede che ci siano altri fattori meritevoli di considerazione. Infatti, secondo lui, credere in Dio aumenta nell’individuo la consapevolezza che la vita sia ricca di significato. “C’è più di una ragione per crederlo – una è sicuramente il senso della comunità e del rafforzamento delle relazioni sociali, ma non è tutto. Una gran parte del merito va al senso, all’impegno e al valore che vi da il credere in un Dio, mentre non credere in niente vi priva di questi valori.”
Alcuni studi precedenti hanno evidenziato che l’essere umano sarebbe biologicamente predisposto a credere in Dio. Storicamente, la maggior parte delle culture hanno sviluppato qualche sorta di credenza religiosa che includesse almeno una forma di “essere soprannaturale”. Viste in prospettiva evoluzionistica e psicologica queste questioni hanno intrigato gli scienziati per decenni, ma gli studi fisiologici e cognitivi sulla religione sono relativamente recenti. Sia i credenti che i non credenti possono convenire sui risultati della ricerca e, nonostante ciò, interpretarli in maniera diversa.
I ricercatori dell’Ian Ramsey Centre for Science and religion dell’università di Oxford stanno lavorando ad un progetto che aiuterà a comprendere meglio la scienza cognitiva della religione, che si propone di cercare la parte razionale che sta dietro la fede. Ossia, cosa induce lucidamente un individuo ad affidarsi al soprannaturale.
“Uno dei fini del progetto è spiegare scientificamente non solo la fede in un Dio, ma anche il motivo per cui alcune persone divengono atee. Se gli scienziati riusciranno a spiegare perchè le persone tendono a credere o meno in un’entità superiore allora i non credenti potranno trovare una spiegazione soddisfacente in merito alla fede altrui, poichè ora gli atei, trovano difficile comprendere il motivo per cui molte persone credono in esseri inesistenti supportati da storie senza fondamento reale.”